PAESAGGI IMMAGINARI, PAESAGGI REALI E PAESAGGI ETNICI
 di Luogoespazio (D.P.)
di Luogoespazio (D.P.)
Quando si pensa alla parola “paesaggio”, di norma si affacciano alla mente immagini ambientali, sospese fra il documentario televisivo e la pubblicità turistica, che spaziano dal mare alle colline, dalle montagne ai laghi, ma che sono in fondo accomunate da un aspetto: la prevalenza della componente fisico-naturale. Eppure, se andiamo a controllare la Convenzione Europea del Paesaggio –presentata a Firenze nel 2000 ed adottata ufficialmente dall’Italia nel 2006– si legge nel “Preambolo” che una delle fondamenta del concetto risiede nel riconoscimento che «il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana». In questa accezione, il paesaggio esiste, dunque, dappertutto. Se pensiamo allora alla nostra quotidianità ed a quali scenari spaziali essa attraversa di norma, ne risulta che i “paesaggi” della vita “feriale” non sono fatti –se non per alcune fortunate eccezioni professionali– di cascate, cime innevate, panorami mozzafiato, ma piuttosto di più comuni strade, case, palazzi, città, persone. Già, persone. Le persone fanno parte del paesaggio? Non solo nel senso –assodato nella tradizione geografica– che è l’intervento antropico ad aver plasmato i territori nelle loro attuali fattezze, ma anche nel significato più letterale dell’efficace sintesi proposta dal geografo Eugenio Turri attraverso la metafora del “paesaggio come teatro”: le persone sono anche “attori” che si muovono, consciamente, nello spazio del palcoscenico paesaggistico.
L’immagine “primigenia” ed “incontaminata” di paesaggio dalla quale siamo partiti non contempla necessariamente la presenza antropica, ma la quotidianità dei paesaggi che la maggior parte di noi attraversa certamente sì. Il fotografo Luigi Ghirri, in un suo scritto intitolato proprio L’omino sul ciglio del burrone, si sofferma sul ruolo che nella maggioranza delle fotografie presenti negli atlanti scolastici assolveva la figura umana: «Fin da bambino, le fotografie che mi piacevano maggiormente erano quelle di paesaggio, che vedevo intercalate negli Atlanti con le carte geografiche. Mi affascinavano particolarmente queste fotografie, dove immancabile, immobile, appariva un piccolo uomo sovrastato dalle cascate del Niagara, monti, rocce, alberi altissimi, palme grandiose, o sul ciglio di un burrone. Questo omino lo trovavo poi nelle cartoline, che raffiguravano piazze più o meno celebri, arrampicato sui monumenti storici, disperso nel Foro di Roma. Quell’omino era uno stato di continua contemplazione del mondo, e la sua presenza nelle immagini conferiva a queste un fascino particolare. Non era solo il metro di misurazione delle meraviglie rappresentate, ma grazie a questa unità di misura umana mi restituiva l’idea dello spazio; io lo vedevo in questo modo e credevo, attraverso questo omino, di comprendere il mondo e lo spazio». La riuscita immagine è suggestiva ed evocativa, ma non esaurisce la complessità della presenza umana nei paesaggi che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Come apparirebbe un paesaggio urbano senza persone? Che effetto ci farebbe? Un fotografo americano, Tom Baker, in una recente serie fotografica intitolata “Los Angeles without traffic”, ci restituisce diversi scorci spettralmente deserti di ogni diretta apparizione umana all’interno di una città di norma brulicante perlomeno di traffico automobilistico. Questi scatti hanno qualcosa di inquietante, di “innaturale” nel loro rimandare costantemente ad un’assenza, ad una presenza implicita, quella umana, che rimane però rigorosamente potenziale. Le sue fotografie sembrano rimandare piuttosto ad un immaginario apocalittico e post-atomico frequentato ripetutamente nel cinema hollywoodiano.
Paesaggi pieni o vuoti di persone, dunque? Pensiamo ad una pratica invalsa nella progettazione architettonica: per evitare l’effetto “deserto-urbano”, gli architetti disseminano di figure le loro creazioni progettuali, sia sulla carta sia sullo schermo. Osserviamo con attenzione qual è l’umanità che “abita” questi mondi urbanistici immaginari. Il pianeta dei “rendering” è popolato di famiglie apparentemente felici (di solito ben chiaramente articolate: mamma bionda, papà moro, un bambino ed una bambina; opzionale, ma frequente, il fatto che il bambino abbia in mano un palloncino), di businessman in giacca e cravatta con la borsa sotto il braccio, di donne in eleganti tailleur. Tutti/e, o quasi tutti/e, di aspetto sano, sportivo, magro; tutti/e rigorosamente di pelle bianca, fluttuanti in uno spazio di apparentemente eterna primavera. Probabilmente i progettisti pensano che questo tipo di “paesaggio umano” sia il più appetibile, il meno disturbante: il panorama antropico ideale. E può accadere che anche a noi, distratti osservatori, esso appaia così, o meglio che non si noti nulla di strano, perché questo tipo di umanità è quella di “default” potremmo dire, nell’immaginario urbano astratto. Eppure, se facciamo il confronto con quello che vediamo nella realtà di tutti i giorni, la corrispondenza non è propriamente perfetta.
Il nostro immaginario geografico non solo si nutre di elementi paesaggistici, ma tende anche ad inserire, più o meno automaticamente, le correlate presenze umane. In ogni paesaggio immaginato nella nostra mente, in particolar modo in quelli urbani, tendiamo perciò ad immaginare presenze antropiche di un certo tipo, con un certo aspetto, determinate posture, vestiti, presumibili ruoli: “Dimmi che paesaggio vuoi e ti dirò chi metterci”. Questo “paradigma implicito” della componente umana dei paesaggi tende a definire uno standard di “normalità” e quindi di “accettabilità” di quello che poi vediamo effettivamente nella realtà. Se l’osservazione dal vivo si distacca troppo da questa che è la “formattazione” ideale della figura umana nei paesaggi, la nostra percezione sarà profondamente influenzata. E il paesaggio, ci ricorda la Convenzione Europea, è fondamentalmente risultato di un atto percettivo: «‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni».
La questione diventa centrale qualora si prenda in considerazione la variabile “etnica”. Il termine è da prendersi, con le dovute pinze, ovviamente, e nella sua accezione più “neutra” ed allargata possibile. Viene in soccorso la definizione che un sociologo della The New School di New York, Arjun Appadurai, dà di “paesaggio etnico” (ethnoscape nell’originale inglese, dal libro Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization del 1996): «quel panorama di persone che costituisce il mondo mutevole in cui viviamo: turisti, immigrati, rifugiati, esiliati, lavoratori ospiti, ed altri gruppi e individui in movimento costituiscono un tratto essenziale del mondo e sembrano in grado di influenzare la politica delle (e tra le) nazioni ad un livello mai raggiunto prima». Attenendosi ad una delle possibili direzioni di riflessione proposte da Appadurai, i “paesaggi etnici” sono dunque quelli che ci ricordano costantemente che l’umanità è mobile, che le persone si spostano continuamente, che nello stesso luogo, in ogni momento, si incontrano itinerari biografici provenienti dalle più diversificate geografie personali.
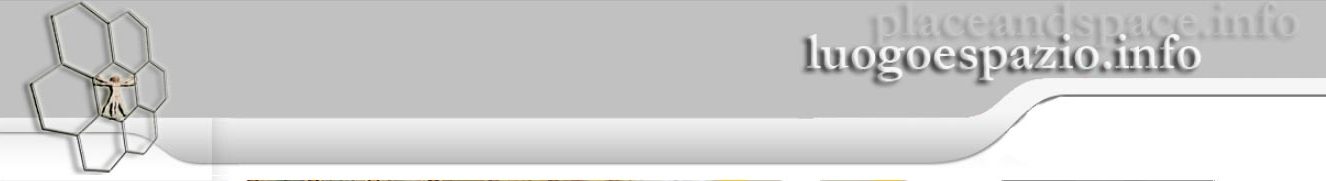



Commenti recenti