PASTA, PELATI E BURQA
 di RB
di RB
Le immagini di donne (arabe) intrappolate in veli e abiti che assomigliano più a gabbie che a vestiti, sono diventate talmente comuni da passare ormai inosservate, quasi quanto quelle delle donne (italiane) (s)vestite di aderenti e microscopici costumi. Se queste ultime (s)popolano lo spazio mediatico, le prime riempiono lo spazio del consumo, confondendosi tra le scatole di pasta e pelati degli scaffali dei supermercati. Se un tempo per trovare un libro che parlasse di mondo arabo e Islam era necessario rivolgersi alle librerie specializzate, se la letteratura femminile e i romanzi delle narratrici arabe erano oggetto di studi specialistici, se le immagini delle donne erano confinate nelle tele dei pittori orientalisti, oggi sembra che sia possibile aumentare il proprio capitale culturale sul mondo arabo mentre scegliamo gli ingredienti per la cena.
L’11 settembre 2001 ha prodotto tra i mille effetti anche una diversa luce sull’Islam e, tra gli altri aspetti, quello del ruolo delle donne. Tutti i recenti episodi di cronaca che hanno coinvolto la comunità musulmana in Italia hanno riguardato molto spesso le donne immigrate o nate da genitori immigrati. Gli articoli dei quotidiani hanno puntato l’accento in alcuni casi sulla fatidica opposizione tra tradizione (rappresentata dai padri) e modernità (rappresentata dalle figlie) oppure sulla segregazione a cui sembrano costrette le donne musulmane nella loro totalità, come fossero un blocco monolitico e omogeneo. Il confinamento in uno spazio, quello della casa, sembra poi la conseguenza più naturale e reale, idea supportata e legittimata da quella letteratura pseudo-specialistica accolta tra le braccia rassicuranti di molte case editrici italiane che, attraverso le supposte biografie o testimonianze di ‘quelle che il fatto l’hanno vissuto’ sembrano dar voce alle donne arabe oppresse.
Il mondo musulmano però è molto vasto e ingloba in sé molti paesi e, di conseguenza, molte società che si differenziano in maniera significativa le une dalle altre. Bisogna quindi fare molta attenzione a non confondere i precetti dettati dal Corano con le interpretazione che le varie società, guidate sempre da uomini, ne hanno dato nel corso del tempo e l’uso strumentale che di esso ne hanno fatto. E’ difficile, infatti, stabilire quanto delle evoluzioni del rapporto tra maschio e femmina sia da attribuire al Corano, quanto invece dipenda da interpretazioni successive e quanto ancora da concrete pratiche sociali.
Non bisogna poi dimenticare come la società occidentale, tramite i racconti di viaggio prima, le relazioni dei comandanti delle colonie poi e i mass media oggi, ha volto lo sguardo verso le donne musulmane e in particolare arabe, applicando certi parametri e modelli estranei a quei contesti. Mi riferisco, tra le altre cose, alla questione del velo, elemento che ha avuto un grosso impatto soprattutto sulle donne occidentali per il suo valore nella costruzione delle identità, non solo delle donne musulmane ma anche, per opposizione, di quelle occidentali. Secondo quanto spiega Vercellin (Tra veli e turbanti. Venezia: Marsilio, 2000), del velo come viene oggi inteso in occidente non c’è alcuna traccia esplicita nel Corano. Il termine hijab, tradotto con velo, viene impiegato nel senso di tenda, cortina dietro alla quale, ad esempio, può avvenire persino la Rivelazione. Il Corano (24/31 e 33/59) parla di indumenti femminili che sembrano avere più che altro un carattere di tutela del comune senso del pudore: “E dì alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro vergogne e non mostrino troppo le loro parti belle altro che ai loro mariti o ai loro padri […] e non battano assieme i piedi sì da mostrare le loro bellezze nascoste”. E ancora “O Profeta! Dì alle tue spose e alle tue figlie e alle donne dei credenti che si ricoprano dei loro mantelli [jalabib]; questo sarà più atto a distinguerle dalle altre e a che non vengano offese”. Jilbab, jallabiya potrebbe rivelarsi un predecessore dell’attuale ‘velo islamico’ anche se non è affatto sicuro che nascondesse il viso. Ciò che invece è sicuro è il fatto che esso rappresentasse un segno di distinzione per gli appartenenti alla nuova comunità islamica. Ad ogni modo, la questione del velo ha portato spesso a sollevare critiche ma soprattutto ad alimentare un certo immaginario che ha costruito figure femminili molto spesso lontane dalla quotidianità vissuta da molte di queste donne.
Questo immaginario ha preso come sfondo alcuni luoghi considerati assoluto appannaggio della donna come l’harem o l’hammam, spazi completamente estranei alla cultura occidentale sui quali, di conseguenza, si sono concentrate le fantasie della società europea. La parola harem, ad esempio, come spiega Fatima Mernissi (L’Harem e l’Occidente. Firenze: Giunti, 2000) evoca alla mente immagini di donne in atteggiamenti lascivi, in continua attesa di qualcosa o di qualcuno, un voluttuoso paese delle meraviglie intriso di sesso sfrenato, entro cui le donne, vulnerabilmente nude, erano felici di essere rinchiuse. In realtà, la parola harem deriva dall’arabo haram nell’accezione di sacro (proibito, interdetto, inaccessibile). Con harim si intende un luogo separato, perciò tagliato fuori dallo spazio profano. La sfera semantica di riferimento è quella del ‘sacro’ islamico, che è un territorio, un tempo, un cibo incontaminato, inviolabile, inaccessibile. L’harem quindi identifica quello spazio dell’abitazione riservato alle donne, alla vita privata della famiglia contrapposta a quella pubblica.
Nella società musulmana i luoghi hanno un’importanza determinante perché il gioco dei ruoli è fortemente regolamentato dalla netta divisione tra spazio pubblico e spazio privato. La divisione spaziale, infatti, concretizza il modo in cui la società concepisce il rapporto uomo/donna, collocando l’uomo come ‘situazione sociale’ alla ricerca del piacere e la donna come fonte di piacere continuamente sfruttabile. Questa visione naturalizza l’idea che lo spazio pubblico sia predominio degli uomini e ad essi consacrato, mentre lo spazio privato sia appannaggio delle donne e, secondo il discorso islamista, l’unico posto ‘giusto’ per la donna. Alcuni hadith (detti del Profeta) e versetti del Corano sono stati interpretati per avallare questa tesi, partendo dall’idea che all’interno della divisione dei ruoli imposta dalla religione musulmana, la donna abbia il dovere di gestire bene la casa, di preservare i segreti della vita coniugale e di provvedere all’educazione dei/lle bambin*.
Il Corano dedica una quantità ridondante di passi che trattano il matrimonio e le relazioni sessuali, al contrario esiste un unico versetto che autorizza la poligamia, un’altra caratteristica della società musulmana che ha tanto affascinato e incuriosito gli occidentali. “Se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora di fra le donne che vi piacciono due, tre o quattro, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso; questo sarà più atto a non farvi deviare” (Corano 4/3). Alla luce di ciò, alcun* riformist* sostengono che in realtà questo versetto non autorizzi veramente la poligamia, data l’impossibilità umana di equità assoluta.
Nell’Islam esiste una forte opposizione tra privato e pubblico, dentro e fuori, interno ed esterno, che è gestita all’interno di uno spazio sociale al punto da diventare portatrice di significato, in quanto veicola delle rappresentazioni che rimandano all’organizzazione sociale e culturale in generale. Come sostiene Bourdieu, infatti, “L’atto culturale per eccellenza è quello che consiste nel tracciare quella linea che dà vita ad uno spazio separato e delimitato”. Sebbene nelle società musulmane lo spazio interno sia stato sempre percepito e descritto come uno spazio di esclusione e di clausura delle donne, in rapporto allo spazio esterno, considerato all’insegna dell’apertura e della realizzazione degli uomini, questa caratteristica non è prerogativa dell’Islam ma accomuna tutte le società patriarcali. I media, invece, tendono molto spesso ad enfatizzare le differenze invece di porre l’accento sulle similitudini. Nei due casi di cronaca delle ragazze musulmane uccise dai padri, la stampa ha spesso strumentalizzato i fatti per alimentare la supposta distanza tra i musulmani e i cristiani, arrivando a volte a concludere (in maniera diretta o indiretta a seconda delle testate) che l’integrazione dei/lle migrant* di religione musulmana sia difficile quando non impossibile. L’uso ricorrente dell’aggettivo ‘occidentale’ (“vestiva all’occidentale”, “aveva uno stile di vita occidentale”) presupponeva in maniera tacita l’appartenenza di questi padri ad una supposta cultura ‘orientale’.
L’uso della metafora geografica permette, allora, di legittimare l’esistenza di due entità geografiche opposte: oriente e occidente. La riflessione si inserisce così in quel percorso teorico tracciato da Samuel Hungtington nel suo libro “Scontro di civiltà”, piuttosto che in quello di Edward Said che in “Orientalismo” già alla fine degli anni ’70 dimostrava efficacemente come l’‘oriente’ sia una costruzione dell’‘occidente’. Said però resta in biblioteca o nelle librerie mentre i libri di storie di donne velate, oppresse, rinchiuse, che non tengono in considerazione tutte le variazioni che si possono osservare nella condizione delle donne nel complesso del mondo arabo, sono facilmente accessibili e diventano mezzi potenti per la costruzione del discorso sullo ‘scontro’. Ci consola però pensare che, forse, occupano lo spazio che meritano: quello nello scaffale di fianco ai pelati…
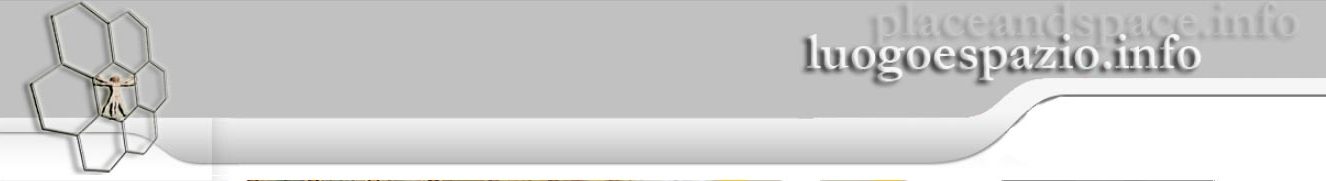




Commenti recenti